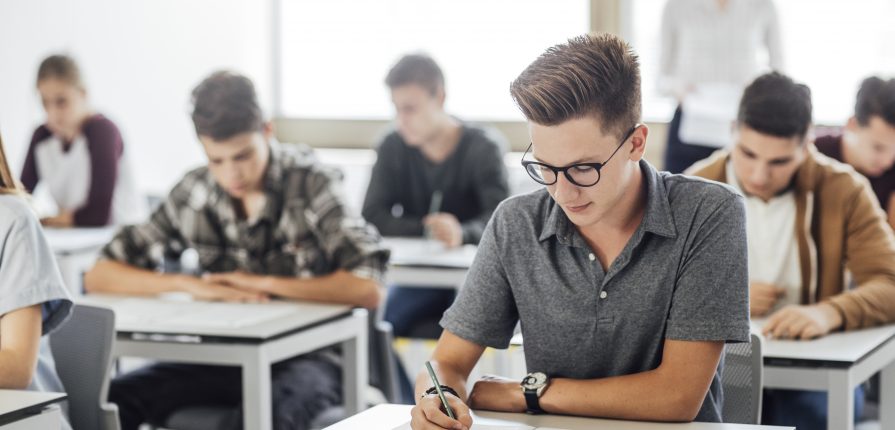La scuola per vivere ha bisogno di risorse strutturali, strumentali, tecnologiche, ma anche di insegnanti e alunni impegnati in due azioni complementari: insegnare e apprendere. Queste due azioni sono state interrotte dall’emergenza del Coronavirus e sono state recuperate encomiabilmente, pur tra alcuni limiti, attraverso la didattica a distanza. Abbiamo sperato tutti (insegnanti, genitori, alunni stessi) di poter tornare nelle aule scolastiche per assicurare una relazione educativa calda, una socializzazione tra pari, l’alleggerimento del peso riversato sui genitori, spesso preoccupati dalle loro situazioni lavorative o persino affranti dalla perdita di persone care.
L’esame di maturità
Purtroppo il ritorno a scuola in maggio sembra non sia ritenuto possibile dagli esperti e il ministero è chiamato ad emanare, ai sensi decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, le ordinanze che forniscano indicazioni sulla valutazione finale degli alunni e sullo svolgimento degli esami a conclusione del primo ciclo (terza media) e del secondo ciclo (maturità). Il ministro ha già firmato l’ordinanza per lo svolgimento dell’esame di maturità che consisterà solo in un colloquio orale, da svolgere alla presenza di una commissione composta da sei commissari interni e da un presidente esterno.
Scuola media. Figli di un dio minore?
Per il primo ciclo non ancora abbiamo l’ordinanza, ma sappiamo che il decreto legge prevede la sostituzione dell’esame con “la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza…”. Rimanendo fermi a quanto disposto dal decreto si deduce che l’esame finale del primo ciclo, a differenza di quanto avviene nel secondo ciclo, non ci sarà. Viene da chiedersi subito il perché. Gli studenti di scuola media sono forse figli di un dio minore? Sono forse più fragili tanto da non poter sostenere un colloquio? Oppure questo esame non ha lo stesso valore di quello sostenuto dai fratelli maggiori?
La necessità dell’esame: le ragioni giuridiche
La mia risposta a questi interrogativi si trasforma in una proposta: richiediamo anche agli studenti del primo ciclo di sostenere l’esame attraverso un colloquio e proponiamo un emendamento in sede di conversione in legge del decreto legge 228/2020. Ci sono prima di tutto ragioni giuridiche. L’esame è richiesto dalla nostra Costituzione che all’art. 33 così recita: “È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. Forse è da chiedersi se la valutazione in assenza dell’alunno e sulla base di un semplice elaborato possa intendersi “esame” secondo il dettato costituzionale. Qualche dubbio sorge se ci riferiamo alla definizione di esame, data dai dizionari.
Prendo quella riportata dal Dizionario Treccani:
“Attenta osservazione cui si sottopone un oggetto o una persona e le varie sue parti per conoscerne le qualità… Prova, variamente costituita e condotta, mediante la quale viene accertata la preparazione conseguita dagli studenti nelle scuole dei diversi tipi e gradi, o privatamente”.
Forse la sostituzione dell’esame con una semplice valutazione che non prevede la presenza del candidato non corrisponde in pieno al dettato costituzionale, ma tralascio queste argomentazioni che rimetto all’approfondimento dei giuristi e mi concentro sulle ragioni educative, istituzionali, civiche, simboliche.
Le ragioni educative
L’esame finale del primo ciclo non ha solo un valore giuridico e non è, quindi, finalizzato semplicemente a rilasciare un diploma che consenta l’accesso all’ordine di scuola superiore oppure ai concorsi pubblici o ancora al mondo del lavoro quando l’obbligo scolastico si concludeva proprio alla fine della scuola media. Con il tempo questo momento conclusivo della scolarità media ha assunto sempre più un significato educativo, messo in risalto molto bene dal decreto ministeriale 16.08.1981 che asseriva:
“L’aspetto fondamentale di questo esame deve essere la sua caratterizzazione educativa in quanto, a conclusione della scuola obbligatoria, deve essere offerta all’alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte successive. L’esame di licenza media avrà, pertanto, il carattere di un bilancio sia dell’attività svolta dall’alunno sia dell’azione educativa e culturale compiute dalla scuola, anche per una convalida del giudizio sull’orientamento.”
Una prova formativa
L’esame consiste, come sappiamo, in una serie di prove ed è percepita dagli stessi alunni come una prova. Gli studi di settore e l’esperienza hanno dimostrato che gli adolescenti vanno alla ricerca di prove in ogni campo per costruire le loro identità, per avvicinarsi al mondo adulto, in definitiva per constatare la loro crescita. Spesso sono le cosiddette “prove di coraggio” anche rischiose per la loro incolumità, ma che comunque aiutano a crescere. Nella vita non ci sono solo prove fisiche, ma anche prove in cui dobbiamo fare ricorso alle nostre capacità, alle nostre risorse, alle nostre attitudini. E ne sono molte. Ebbene l’esame finale del primo ciclo è la vera prima prova che l’adolescente si trova ad affrontare. Di fronte ad essa non si pone con indifferenza, ma con un sentimento di attesa e persino di ansia che richiede di raccogliere le proprie energie e di dare prova di sé. Ecco perché l’esame di terza media ha una grande funzione formativa. Abolirla anche in un periodo di emergenza significherebbe privare gli adolescenti di una prova importante.
Le ragioni istituzionali e civiche
Spesso lamentiamo che oggi i giovani (e non solo loro) non hanno il rispetto delle istituzioni e non hanno maturato una adeguata coscienza civica. Le indagini mettono in risalto che gli italiani, almeno dal secondo dopoguerra, si sono sempre distinti per un sostanziale discredito nei confronti delle istituzioni e che la sfiducia dei cittadini, e in particolare delle giovani generazioni, nelle istituzioni è ulteriormente aumentata. Il preadolescente respira questo clima, assume atteggiamenti anche reattivi e oppositivi alle figure istituzionali, ha bisogno per uscire da questo stato di diffidenza di avere prove istituzionali, di poter constatare concretamente che l’istituzione esiste e che anche in periodi di difficoltà non abdica a un suo compito essenziale, anzi si mantiene visibile e viva pur accomodandosi a situazioni emergenziali.
È una bella occasione questa per dire che l’istituzione c’è. Non possiamo portare avanti l’insegnamento di Educazione civica, introdotta recentemente in ogni ordine e grado di scuola, se poi l’istituzione proprio in questo periodo si eclissa.
Le ragioni motivazionali e simboliche
Gli alunni hanno percepito per l’intero anno scolastico l’importanza di questo momento finale. È stato richiesto loro un maggiore impegno sia dai genitori che dai docenti. Hanno anche dato, ciascuno nelle sue possibilità, una risposta responsabile a questa attesa. L’esame ha avuto anche una forte propulsione motivazionale ed è stato caricato di attese di eventuali apprezzamenti e gratificazioni. Non si può negare nemmeno il valore simbolico che questo momento assume con la restituzione di valore che gli insegnanti fanno ai ragazzi sul loro impegno e sulle loro esperienze vissute sia a scuola che nella didattica a distanza. Non possiamo dimenticare che spesso il successo ottenuto nell’esame o anche la semplice presa di coscienza di averlo superato è fonte di soddisfazione, rafforza la fiducia in sé e la possibilità di riuscita nella scuola del secondo ciclo.
Le ragioni del cuore
Ci sono anche ragioni che non appartengono alla ragione, ma ai sentimenti. Gli studenti hanno stabilito un legame molto forte con la scuola e con i loro docenti. Nella maggior parte dei casi sono sorti legami di fiducia, di stima, di affinità elettive, tra insegnanti e alunni. L’esame rappresenta anche la conclusione di un cammino compiuto insieme, il momento in cui si raccolgono si realizza distacco relazionale, fatto di saluti informali, di formule augurali per il futuro. Sarò retorico, ma l’esame è anche un momento di galateo istituzionale e relazionale.
Un colloquio d’esame
Per tutte le ragioni sopraesposte ritengo si possa richiedere anche per gli studenti del primo ciclo un colloquio orale in cui discutere con la commissione, composta dal consiglio di classe, una ricerca da loro effettuata o un elaborato. È possibile mantenere anche il distanziamento sociale disciplinando gli ingressi degli alunni nell’aula prescelta e salvaguardando persino la trasparenza. Se proprio la presenza dell’alunno si ritenga ancora pericolosa, il colloquio venga anche svolto a distanza in modo da dare una risposta, seppure contenuta, a quanto richiesto dall’articolo 8 decreto leg.vo n. 62 del 13 aprile 2017:
“Il colloquio e’ finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.”