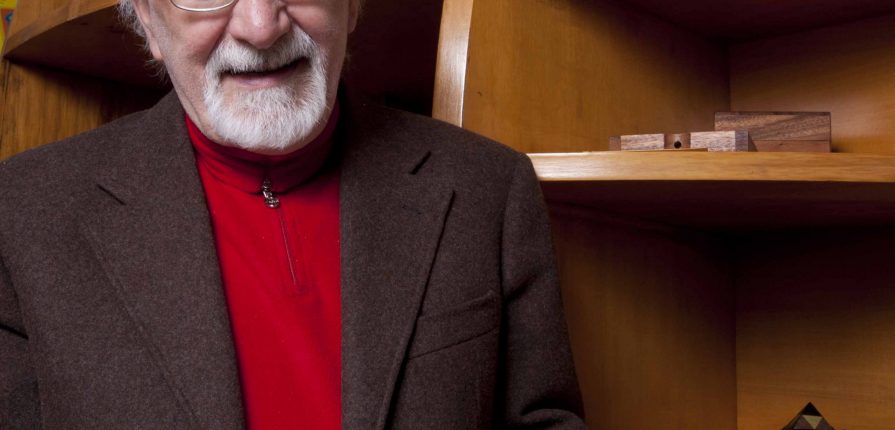Si va diffondendo da qualche tempo, nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e nel primo anno della scuola elementare, uno strano insegnamento dell’alfabeto, con una sorta di solitudine obbligatoria delle consonanti, nel senso che le consonanti si insegnano senza chiamarle per nome. Essendo, però, necessario comunque nominarle per poterle insegnare, è stato adottato il sistema di accompagnare le consonanti ad un suono simile alla «e» muta francese. Evidentemente, ciò viene fatto con l’idea di facilitare il bambino nel riconoscimento e discriminazione delle lettere alfabetiche: supponendo, cioè, che il bambino impari meglio a leggere e scrivere le lettere senza conoscerne il nome e magari sommandole sotto dettatura ad una ad una. Il risultato sarà che i bambini non comprenderanno – o comprenderanno più tardi e con più fatica – che lo scopo della lingua non è il “compitare” con l’alfabeto ma comporre (e analizzare) parole, frasi, discorsi: insomma, produrre e ricevere significati.
Nessun insegnante o genitore deve trascurare il fatto che l’attività dell’apprendere, come quella del comunicare e/o ricevere comunicazione, deve sempre essere accompagnata da significati.
Le lettere dell’alfabeto hanno ciascuna un proprio nome: a, bi, ci, di, e, effe, ecc. In verità, non è frequente scrivere il nome delle lettere dell’alfabeto. Ma pronunciarlo sì, in italiano e in tutte le altre lingue basate sull’alfabeto. Con una particolarità: che le vocali sono visonomatopeiche, cioè formano il proprio nome (dal greco onoma-nome, + poieîn-fare) con il solo presentarsi alla vista; le consonanti, al contrario, non sono in grado di farsi leggere da sole e, quindi, per avere un proprio suono e un proprio nome, hanno bisogno di essere unite a vocali, cioè “suonano” insieme alle vocali e perciò si chiamano consonanti.
È, quindi, un errore chiamarle in modo diverso da bi, ci, di, ecc. Così come, passando all’aritmetica, è un errore far apprendere i diversi valori delle cifre in base ad un marchingegno di colori diversi invece che in base alla posizione che ogni cifra occupa nell’ambito di un numero. In entrambi i casi – nell’alfabeto e nella numerazione – vengono applicate e praticate, nella veste di “apparati facilitanti”, vere e proprie complicazioni: nel senso che i bambini imparano una cosa non corretta (come il sistema decimale a colori o il nome sbagliato delle lettere), e poi debbono disimpararla – dimenticarla – per fare posto all’apprendimento corretto.
Apprendimenti – scorretti – di questo tipo possono essere parzialmente perdonati nei casi di didattica compensativa, qualora l’allievo non riuscisse, a causa di difficoltà e scompensi nell’apprendere, a sviluppare i concetti esatti di un dato argomento: in tali casi, ci si accontenta di rinunciare, per cause di forza maggiore, allo sviluppo di concetti compiuti, sostituendoli con i loro surrogati. È un placebo sul piano psicologico, ma non certo l’acquisizione di un sapere adeguatamente sviluppato e compreso.